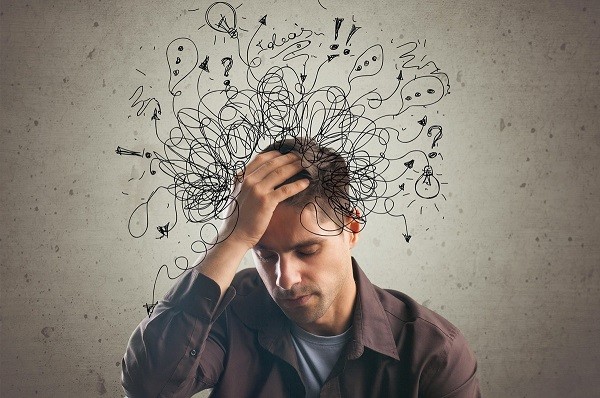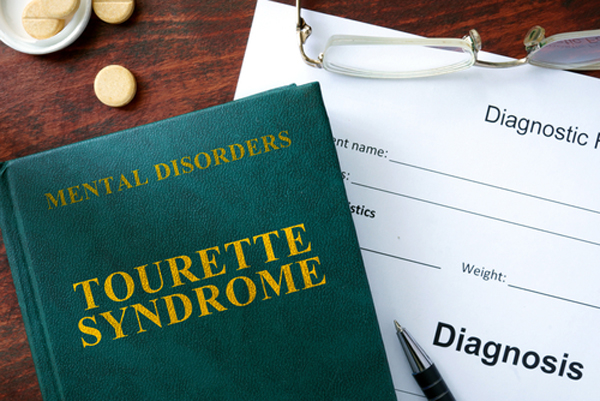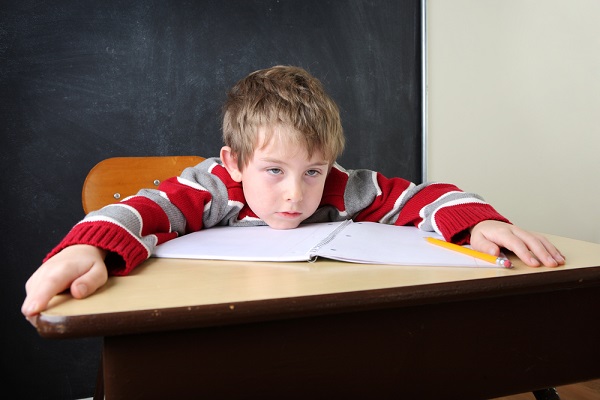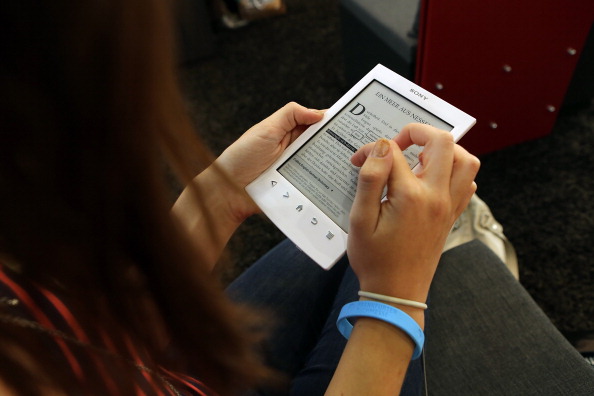deficit di attenzione
Bambini, il metilfenidato (Ritalin) blocca la crescita
L’organo ufficiale della farmacovigilanza italiano
Psicofarmaci per bambini iperattivi, possibili danni per il sistema cardiocircolatorio
Anche in pediatria, il ricorso
Allarme psicofarmaci in Italia: sono circa 70 mila i bambini che li ricevono
Un inquietante dato viene riferito
Deficit dell’attenzione e iperattività: due proteine le colpevoli
C’è un’origine chimica nel disturbo